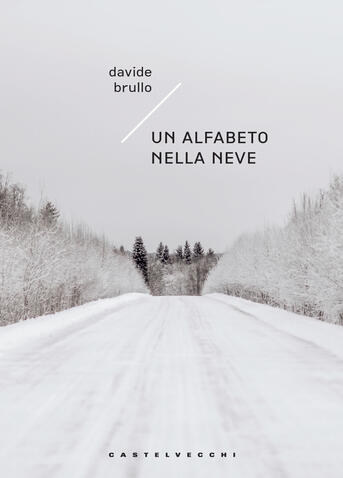 UN ALFABETO NELLA NEVE di Davide Brullo (Castelvecchi)
UN ALFABETO NELLA NEVE di Davide Brullo (Castelvecchi)
* * *
Brullo è il re dell’apocrifo. I suoi romanzi sono palle di fuoco. E “Un alfabeto nella neve” è fatto per ustionare
di Gianluca Barbera
Consentitemi di chiamare il personaggio principale del romanzo Davide Brullo. Quello che trovate indicato in copertina altri non è che il suo fratello gemello. Mettiamola così.
Si comincia con un pugno di lettere lasciate al nostro eroe (decidete voi se l’autore o il personaggio) da un’anziana signora russa che vive ritirata sul Lago Maggiore. Si tratta nientemeno che del carteggio, ritenuto perduto, tra Boris Pasternak e Marina Cvetaeva, due tra i maggiori poeti del Novecento. Tra loro divampò una passione a distanza, mai consumata. Entrambi notoriamente facili ad accendersi. Ma non dovete dimenticare che il nostro Brullo è un abile mistificatore, un vero mago della parola, un forgiatore di vertigini e di pensieri urticanti, più difficili da maneggiare di palle infuocate. Nel romanzo (nella sua vita reale non vogliamo entrare) egli colleziona esistenze, si cala negli abissi di artisti e letterati illustri, riporta alla luce documenti scomparsi, rinviene testi inediti, li inventa, se necessario. Dà letteralmente vita a nuovi personaggi fiammeggianti. Questa demiurgica forza lo fa sentire onnipotente (è lui stesso ad ammetterlo). Le sue rivelazioni, i suoi libri, mirano a provocare sconquassi “nel ghiacciaio della storia dell’arte”. Egli non è nuovo a scoop, a scandali. È proprio di quelli che va in cerca. Non esita a vantarsi dei suoi successi. Ricorda di aver pubblicato “un soggetto di Ingmar Bergman che narra le perversioni sessuali di Franz Kafka”; di aver fornito le prove “della pederastia ossessiva di Giorgione” e di aver dato alle stampe “una lettera in cui James Joyce ammette di aver violato la figlia matta”. È riuscito nell’impresa di persuadere il mondo letterario che “Hemingway era affamato di uomini e che ha avuto una relazione con Simenon”. In breve, il nostro è un biografo che ama “dissacrare i miti e disonorare i riti”.
L’anziana signora russa che gli concede i suoi favori – di nome Ingrid – afferma di avere conosciuto Boris Pasternak. E questo la rende interessante. Per di più possiede il prezioso carteggio di cui sopra. Come ne sia venuta in possesso non è dato sapere. Le notizie sul loro conto si perdono in un oscuro passato. Pare che il grande scrittore russo avesse affidato le lettere scambiate con Marina Cvetaeva – ardenti di passione, letteratura, spunti sulla vita – a un’amica impiegata al Museo Skrjabin di Mosca. Sono lettere “estreme e lunari”. Valgono una fortuna. Quest’amica le ama così tanto da portarle sempre con sé nella borsetta. Ma un giorno si addormenta sul tram (“il caos si consolidò nel sonno e mise tana nelle palpebre dell’impiegata”) e le smarrisce. Il giorno dopo la guerra raggiunge Mosca e delle lettere si perde traccia. Probabilmente sono servite ad alimentare il fuoco di un camino nelle gelide notti moscovite – a causa della guerra vi è penuria di tutto. È così grave? A quanto pare no. “Se vuoi custodire una cosa, la perdi; ciò che proteggi, si distrugge” commenta il nostro. E inoltre “il vero compito della letteratura è diventare fuoco perché un altro, sconosciuto, si riscaldi”. La mano del caos governa le cose. Pagina dopo pagina si insinua il sospetto che sia stato lo stesso Pasternak a distruggerle “in uno di quei giorni in cui si ostinava a cambiare vita eliminando delle parti di sé”, poiché “egli, scrivendo, desertificava il passato”. Non è forse vero che “si scrive per sopprimere il passato”? E che, “dal momento che gli uomini, gli amici, gli amanti, ci confinano al presente, a ciò che siamo, gravandoci con le catene della memoria”, proprio “per questo lo scrittore, alieno tra gli uomini, ha fame di solitudine”?
Dimenticavo di dirvi che per avere quelle lettere il nostro cacciatore di biografie ha dovuto tenacemente corteggiare l’anziana signora. Ecco come: “Cominciai a scriverle e a farle visita; lei sembrava sapere tutti gli stratagemmi dell’esistenza. ‘Se vuole la mia vita – perché di questo parliamo – mi dia, almeno, la sua’ mi scrisse”. Ma la verità è che, se lei accetta di lasciarsi corteggiare, è solo perché egli somiglia al di lei cugino, il celebre scultore Paolo Troubetzkoy. Il mistero s’infittisce. Il nostro vuole impossessarsi non solo delle lettere ma anche dell’anima di Pasternak (anche se in realtà è delle proprie origini che va in cerca, anche se solo per cancellarle). Ma lei lo gela: “Non lo divinizzi: Pasternak ha rovinato la vita a diverse donne, non solo a quelle che ha impalmato. D’altronde ogni uomo, non appena impara a giocare con le frasi, intralcia gli altri, mente”. Eppure il nostro Brullo letterario non demorde. La vecchia non ha parenti né eredi designati. E lascia intendere che potrebbe lasciare ogni cosa a lui. Più in là si scoprirà che l’anziana signora ha giocato un ruolo di primo piano nella vita di Pasternak, ben al di là di ciò che ha lasciato intendere. Ma ovviamente non vi dirò quale. Il mistero è solo uno dei mille volti seducenti del libro. Così come le figure di Pasternak e della Cvetaeva emergenti a poco a poco dal carteggio (che costituisce il filone principale del romanzo) sono così fiammeggianti da ustionare. Non vorrei dirvi troppo riguardo alle lettere, eppure qualcosa andrà detto. Anche perché sono percorse da passi così febbricitanti e memorabili che trattenersi dal citarli, almeno in minima parte, è impossibile. E allora apprendiamo che lui, Pasternak, “sembra massiccio come una giungla, ma è impalpabile, voce antica su città di vento”. “Ma tu, tu sei viva, sei mia, Marina?” si ostina a scriverle. Per tutta risposta riceve frasi di granito: “Boris, Boris, tu sei un tiranno e sbocciano tigri dai tuoi denti; gli occhi, invece, sono isole australi su cui domina l’indifferenza delle lucertole. Ogni tua poesia è una condanna a morte – se fossi un re sbricioleresti cifre di città perché la primavera ti annoia. La sofferenza ti è necessaria per l’avida felicità che trasudi. Non mi scrivere più, sodale dei dittatori, anzi, esercita la tua cattiveria su di me: scrivimi solo le parole che sappiano, per la loro forza eccessiva, indurmi al suicidio”. A nulla valgono le sue timide difese: “Come quel re che dipende dall’amore del suo falco, non potrei mai dominarti, Marina, né chiederti per schiava o averti per suddita”. Ma nelle sue lettere il primo posto è preso dalla scena storica. Compaiono qua e là personaggi come Stalin (che chiamava Pasternak “la tigre bianca”): “Quest’uomo che ha potere di morte sugli uomini – che ha ucciso e ordinato di uccidere – non capisce che la poesia è il riscatto dei morti, non ammette il rimorso, la magnetizzazione della malinconia, l’ostinato dibattersi nelle chiacchiere dei vivi”. E ancora: “Mi fa pena chi pensa, allineando degli ordini, di poter uccidere un uomo – chi ritiene di essere il pioniere della Storia, ne è divorato. Stalin crede di agire, ma è agito dalla Storia – reagisce ai propri umori, obbedisce al sussulto dei traditori, all’ossessione delle dicerie. Egli – come altri, prima e dopo di lui – esegue la Storia, senza una volontà propria. Nel cuore, credimi, è un animale spaventato: chi vuole farsi amare in fretta fa in modo di essere temuto. La sua fame è infinita e non si è re perdonando l’omicida ma uccidendo l’innocente”. Mentre, al contrario, è il poeta il vero re, poiché sa togliersi “dalla Storia, ne ammira il cataclisma, come una pioggia prodigiosa che sembra far esplodere le finestre, perché quella pioggia, in realtà, è fatta dagli occhi e dalle mani dei sopraffatti, dei rivoluzionari, dei soldati, dei re – chiedono di essere estratti dall’estinzione melmosa dal poeta. Ma il poeta non fa differenza tra l’acquazzone e la luna, e dorme coinvolto in quella litania di scrosci. Il male, voglio dire, è nell’ipnosi della Storia, che di volta in volta adotta i propri seguaci, a cui elargisce fama e desideri incoerenti. Eppure, il poeta è un sonnambulo, un disadatto, un imperiale incapace: con le parole con cui un re condanna, erige memorabili odi al mattino”. E quand’anche la lettera si chiude con il pensiero rivolto a lei (“Ti desidero Marina, mio mattino”), ecco che subito giunge la feroce replica: “Sei così ingenuo riguardo alla vita, Boris, ingenuo come chi propone il perdono e la riconciliazione universale senza sapere nulla del dolore, del male, del delirio, della morte”. Oppure: “Sono la serva dei tuoi versi, Boris, non di te. Dovresti sapere che tanto è grande la poesia così è insignificante il poeta. Tu sei soltanto la fiamma, pallida, fugace, al cospetto dell’incendio della tua opera, così forte da sfinire l’alba e da comprimere gli oceani in una mano. Se soffio, Boris, tu ti spegni, ma la tua opera si alimenta, splende”. O ancora: “Un uomo deve lasciare tutto per me – sapendo che per lui non lascerò nulla, non rinuncerò a niente”. No, non gli risparmia nulla: “Anche tu sai che non sai amare, Boris – l’amore è necessario per i tuoi poemi e per i tuoi ipotetici romanzi”. “Boris, Boris, alla Provvidenza io sostituisco la copula… cosa sarà dei miei figli? Perché non dovrei ucciderli? Una madre ha anche questo diritto, questa spietata pietà”. “Ho sognato che la mia stanza era un oceano e il letto una lenta canoa. Tu eri un’orca, Boris, mi inseguivi e sul tuo corpo artico erano incisi i segni di tutti i principi che da nord a sud, in ogni continente, ti hanno desiderato”. “Boris, sei così patetico, così atrocemente mortale quando tenti di giustificare le tue porcate con parole celesti”. A nulla vale ricordarle che “le parole vanno mangiate, come mele, accolte come qualcosa di vivo, che respira, che non va commentato ma custodito”.
Dobbiamo tenere presente che Pasternak, l’autore del celeberrimo romanzo Il dottor Živago, successo planetario che ebbe il suo epicentro proprio in Italia, è un uomo tormentato e incompreso, specie in patria: “Diranno che sono complice… diranno perfino che sono stato io a compilare la lista degli scrittori inviati a morire in Siberia. Credere nel male significa credere che alcuni uomini siano giusti – e che altri giustamente meritino la morte – e io non lo credo. Credo che ciò che definiamo ‘male’ dipenda dalle circostanze e quindi dalle scelte”. E dunque “estraneo agli scandali con cui i futuristi allarmavano il ‘buon senso’ e la pace dei borghesi, Pasternak si ritrasse sin dagli inizi in una sua gelosa solitudine, con pochissimi appigli nella realtà. E negli anni tumultuosi della rivoluzione si tenne ancora in disparte, diffidando dei temi politici e di quella poesia tribunizia, in cui s’era invece tuffato Majakovskij con tutta l’anima. Egli passava nel folto delle battaglie, che avrebbero mutato la Russia, come un sonnambulo, destandosi a tratti per annotare con voce assonnata non le gesta del popolo, ma i prodigi del cosmo. Fu accusato perciò di ipocondria e indifferenza; i critici gli diedero colpa della sua solitudine, della sua riluttanza a riflettere direttamente i motivi della società sovietica e, cercando soltanto le lacune ideologiche, non s’accorsero della sostanza positiva di questa poesia, che è soprattutto una grande asserzione di fede nella vita”. E davvero vile è “il modo in cui si sono appropriati del Dottor Živago per difendere o distruggere una ideologia. Nonostante Pasternak l’abbia preteso come pura opera d’arte, volutamente i volgari hanno usato il romanzo definendolo antisovietico, tardo romantico, libertario, controgovernativo. Eppure, in ogni opera somma l’opzione politica è una conseguenza della grandezza estetica – difendere una idea qualsiasi tiene il poeta in ostaggio della banalità. Inseguire la legge del linguaggio – eventualmente, accidentalmente – fa scoprire una verità: che sarà il lettore e non lo scrittore, disinteressato agli assoluti, a valutare. Il dottor Živago non è il capolavoro di Pasternak, è il monumento della sua imperfezione. Pasternak non ha scritto qualcosa di paragonabile alle Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke, ad Anabasi di Saint-John Perse o ai Quattro quartetti di Thomas S. Eliot, opere davvero salvifiche. Pasternak si è ritratto dal capolavoro come da ciò che è vano. Perché Pasternak non era un poeta, è la poesia”.
Comunque sia, dopo la morte della vecchia, il nostro Brullo della finzione terrà per sé le lettere e le darà alle stampe. Sorprendentemente, il libro riscuoterà un grande successo: “I liceali si tatuavano i versi indirizzati dalla Cvetaeva a Pasternak sulle braccia; sulla base delle lettere fu tratto un film, piuttosto patetico, con attori di fama”. La vita del nostro rifiorisce, benché solo in superficie. Pasternak lo ha marchiato per sempre. E difatti poco dopo tutto sembra precipitare: “Avere a che fare con gli uomini è più faticoso che scalare una montagna di ghiaccio. Ai più sembra impossibile concepire una vita vissuta al solo fine di creare una forma – una forma indubbiamente bella per l’artista ma che può apparire orribile a chi la osserva. Mi accusarono di aver scritto un apocrifo, che quelle non erano le lettere di Pasternak e della Cvetaeva. Fu il figlio di Pasternak – un uomo che vive di rendita sui ricordi del padre e che decreta l’autenticità dei ricordi altrui – a guidare l’orda degli indignati”. Ecco spalancarsi di nuovo davanti a sé l’abisso. Fino al colpo di scena finale.
Chi è stato veramente Pasternak? Non certo il più grande scrittore del Novecento; ma di sicuro egli ha incarnato “l’intransigenza dell’arte in contrasto con la Storia”. Mentre “l’Occidente perdeva se stesso nella Seconda guerra, Pasternak lo ha salvato, in una camera in mezzo al bosco, a Peredelkino, traducendo Shakespeare e Goethe, e scrivendo”. Rifiutandosi di raccontare la distruzione che lo attorniava, “come un dio senza fedeli, in una terra vergine ha dato nuovo nome alle cose”, sopravvivendo “a un’era che ha sistematicamente eliminato i suoi poeti, i suoi scrittori più grandi – Isaak Babel’ e Osip Mandel’štam, Vladimir Majakovskij e Sergej Esenin e Marina Cvetaeva e Vasilij Grossman – e altri – da Ivan Bunin a Josif Brodskij a Varlam Sˇalamov – li ha confinati all’esilio o alla prigione. Pasternak si è ancorato all’arte; se l’umanità è perduta, egli ha difeso l’uomo”. E dunque, mentre “gli eserciti hanno accerchiato i continenti”, sopra la testa di Pasternak continuano a scorrere “ le nuvole con la stessa accortezza di sempre, dei giaguari”. La sua fedeltà all’arte è importante quanto la sua opera. Egli “non amava gli specchi, odiava i giochi di concetto, gli scacchi, le carte, perché ‘incantano la mente’ diceva; non indossava vestiti bianchi, ‘preludio a una purezza che non mi appartiene’ e la sua casa era pressoché priva di mobili – ‘bisogna vivere come in fuga, in una tenda’. Riempiva le stanze di discorsi ornamentali, buoni per un romanzo, forse. Preferiva che lo osservassero più che ammirarsi in uno specchio – ‘Sono io nell’aldilà, quello?’ mi disse, un giorno. Quanto alle case, ‘lo spaventava la proprietà – ed essere posseduto, da una donna come da un compito, da una idea’”.
Come avete avuto modo di appurare voi stessi, da ogni parola di Brullo, da ogni sua frase (perché tutte queste lettere non sono che invenzione, seppure incanalate nello spirito giusto), spuntano fiori, arabeschi, fuochi pirotecnici, paesaggi lunari, montagne incantate. Perché Brullo è in letteratura il principe degli “stilisti”, il re dell’apocrifo. Che vi resta, a questo punto, se non procurarvi il libro e abbandonarvi alla sua lettura? Lo trovate in libreria da pochi giorni, edito da Castelvecchi. Affrettatevi, sarà presto esaurito. Ma attenzione, non esiste libro più pericoloso: perché, una volta compresa per davvero la poesia di Pasternak, non resta che uccidersi. Parola di Brullo.
* * *
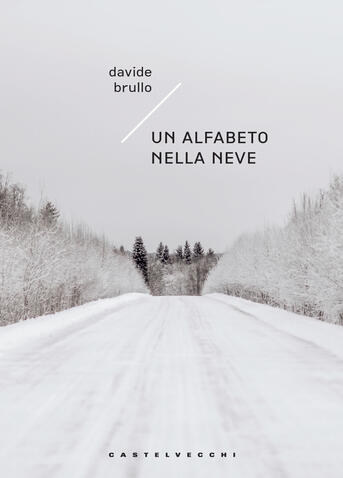 La scheda del libro
La scheda del libro
Un falsario, abituato a trafficare in memorie apocrife di grandi autori e a pubblicare testi corrotti («Amavo dissacrare i miti e disonorare i riti»), un intellettuale fallito, che coltiva il tradimento – nei rapporti umani e “mentali” – come pratica costante, conosce una donna che può cambiargli la vita. Russa, residente sul Lago Maggiore, imparentata con lo scultore Paolo Troubetzkoy, la signora, in punto di morte, consegna al falsario la sua preziosa eredità: il carteggio tra Boris Pasternak e Marina Cvetaeva, andato perduto durante la Seconda guerra mondiale, oggetto bibliografico di grandissimo pregio. L’uomo pubblica il clamoroso documento – riprodotto integralmente nel romanzo – ottenendo l’agognata fama. Una lettera della donna russa, scoperta anni dopo, è la rivelazione che ribalterà l’intera struttura del romanzo, sbriciolandolo, come una nevicata. Ciò che sembrava certo, all’improvviso, apparirà fragile, futile, una necessaria vanità.
* * *
Con Un alfabeto nella neve, Davide Brullo pubblica il quarto volume del Ciclo del Tradimento, costituito dai romanzi Rinuncio (2014), Ingmar Bergman: la vita sessuale di Franz Kafka (2015) e Pseudo-Paolo. La lettera di San Paolo Apostolo a San Pietro (2018). Come poeta ha pubblicato, tra l’altro, Annali (2004), L’era del ferro (2007) e Abbecedario antartico (2017). Scrive su il Giornale e Linkiesta; ha fondato il magazine culturale Pangea, che dirige.
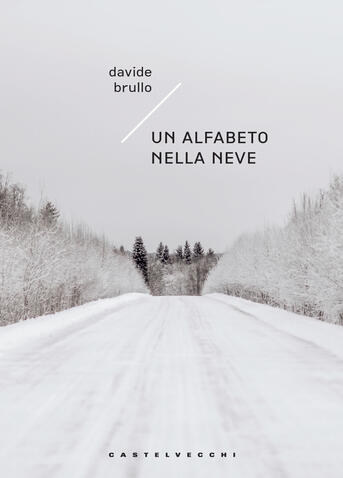 UN ALFABETO NELLA NEVE
UN ALFABETO NELLA NEVE






