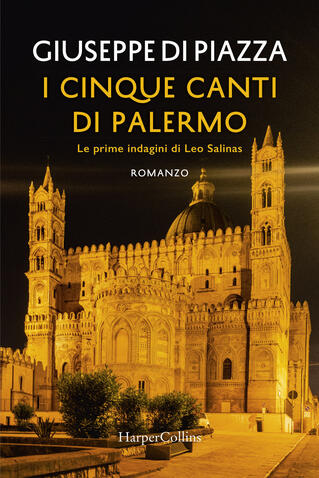 “I cinque canti di Palermo. Le prime indagini di Leo Salinas” di Giuseppe Di Piazza (HarperCollins Italia): incontro con l’autore e un brano del libro
“I cinque canti di Palermo. Le prime indagini di Leo Salinas” di Giuseppe Di Piazza (HarperCollins Italia): incontro con l’autore e un brano del libro
* * *
Giuseppe di Piazza, direttore dell’edizione romana del Corriere della Sera, è stato responsabile dal 2013 di “Corriere Innovazione”, sistema multimediale del Corriere della Sera, e direttore di “Sette” e “Corriere della Sera Magazine”. Ha cominciato la sua carriera giornalistica nel 1979 a “L’Ora di Palermo” dove si è occupato di cronaca. Nell’85 si è trasferito a Roma, lavorando alla rivista del Ministero degli Esteri, poi al quotidiano “Reporter”. Dal 1986 al 2000 è passato al “Messaggero”. Nel quotidiano della Capitale ha svolto i ruoli di capocronista, capo di Interni e Giudiziaria, editorialista, caporedattore centrale. Dalla fine del 2000 si è trasferito a Milano, in Rcs, dove è stato prima responsabile dei contenuti del portale internet del gruppo, poi direttore dell’agenzia radiofonica “Agr”, e dal 2003 direttore del mensile “Max”. Ha pubblicato tre romanzi e fatto diverse mostre fotografiche.
Il nuovo romanzo di Giuseppe di Piazza, pubblicato da HarperCollins Italia, si intitola “I cinque canti di Palermo. Le prime indagini di Leo Salinas”.
Abbiamo incontrato l’autore e gli abbiamo chiesto di parlarcene…
* * *
«Sono dovuti passare tre decenni per trovare la giusta distanza tra me e quello che avevo vissuto all’inizio della mia carriera giornalistica», ha detto Giuseppe Di Piazza a Letteratitudine. «Era la fine degli anni Settanta e io imparavo a fare il cronista, poco più che ventenne, nel più prestigioso giornale antimafia del nostro Paese, L’Ora di Palermo. Intorno a noi i primi fuochi di una guerra che sarebbe durata fino al ’92, con le stragi Falcone e Borsellino e la prima, veemente risposta dello Stato dopo anni di sconfitte.
 Noi raccontavamo il mattatoio di Palermo, lo sterminio da parte di Totò Riina e dei corleonesi di ogni loro avversario, antica mafia palermitana o poliziotti e giudici che fossero.
Noi raccontavamo il mattatoio di Palermo, lo sterminio da parte di Totò Riina e dei corleonesi di ogni loro avversario, antica mafia palermitana o poliziotti e giudici che fossero.
Un racconto che stringeva la gola e ci costringeva a sdoppiarci: da un lato il giornalista con la sua contabilità di morte, dall’altro il giovane uomo, o la giovane donna, con la loro voglia di vita.
Ho impiegato trent’anni, in silenzio, a elaborare quelle sensazioni e farle diventare un romanzo. Non un saggio, che mi avrebbe costretto a scrivere dentro una gabbia di realtà, ma un insieme di narrazioni dove il protagonista, Leo Salinas, una sorta di mio alter ego, poteva sintetizzare in assoluta libertà quei giorni tremendi, in costante equilibrio tra vita e morte, da disperazione e speranza. La sua vita è stata la mia, ma lui – come ogni creatura narrativa – è sicuramente più bravo e più affascinante del suo autore. Un’operazione letteraria di distacco e ritrovamento, per ridare luce (e onore) a una generazione diventata adulta durante una guerra non dichiarata, non percepita dal resto dell’Italia e, fino al ’92, non combattuta in modo adeguata dallo Stato.
Il risultato è adesso nelle pagine de “I cinque canti di Palermo”, scritto una prima volta nel 2010 e oggi riscritto e ampliato. Un romanzo che è lo specchio dove guardo me stesso, i miei amici di allora, il nostro vivere in modo quasi fanciullesco la tragedia quotidiana di una guerra di mafia. Giornalisti impegnati, ma anche ventenni che avevamo voglia di rock, mare, amori. Di giorno penna e dolore, di notte Pink Floyd e sesso. Era quello il modo di salvarci, di resistere – noi con la scorza esistenziale ancora così sottile – a tutto quanto la Palermo dei primi anni Ottanta ci costringeva a vivere. Una Palermo ferita, straziata, ma anche bellissima, con una luce e un odore nel vento che non dimenticherò mai».
* * *
Un brano del romanzo: “I cinque canti di Palermo. Le prime indagini di Leo Salinas” Giuseppe Di Piazza (HarperCollins Italia) – Pagg. 24-27

All’inizio poteva anche sembrare un film western. Piano americano, i duellanti di fronte, a quindici metri uno dall’altro: campo e controcampo. Immagini classiche, tagliate sopra al ginocchio per mostrare i cinturoni e le pistole. Il loro deserto era piazza Scaffa alle tre del mattino. Duecento metri più a ovest, nel 1860, i picciotti di Garibaldi avevano battuto sul Ponte dell’Ammiraglio le truppe di Franceschiello. Quella notte del 1982 altri due picciotti si affrontavano, uno contro l’altro, per una questione di onore e di rispetto. Roba un po’ più complessa di una risibile unità nazionale.
Totuccio Spataro, venticinque anni, detto Peduzzo, killer numero uno della famiglia mafiosa di Ciaculli, arrivò per primo. Il soprannome era dovuto ai suoi piedi minuti, numero trentanove, degni di un trequartista più che di un sicario. La natura, con lui, era stata avara in centimetri d’appoggio e pietà umana. Totuccio si era fatto un nome uccidendo senza alcuna emozione chiunque gli venisse ordinato. Non voleva particolari: solo nome, cognome e un’indicazione sul livello di spettacolarità dell’omicidio; il modo con cui veniva compiuto era l’elemento, per così dire, didattico.
Uccidere qualcuno da una moto in corsa significava rispetto per il bersaglio: difficile da raggiungere e colpire, come le ricciole, che sono pesci carnivori. Altro significava incaprettare la vittima: segno di disprezzo assoluto per un corpo ridotto a un pacco che si autostrangolava; peggio ancora far trovare la vittima, così confezionata, nel bagagliaio di un’auto, sotto il sole dell’estate palermitana.
Totuccio Spataro sapeva impartire con eguale efficacia sia morte, sia lezioni. Ed era imbattibile. Almeno fino a quella notte in piazza Scaffa, quando si trovò di fronte il suo unico cugino che, incredibilmente, aveva scelto di non diventare un killer, tradendo la ditta di famiglia.
Totuccio si guardò intorno, voleva capire se c’era qualcuno nascosto. Si aggiustò con un gesto meccanico la frangetta bruna, che cadeva su un viso fatto apposta per non essere ricordato. Non era alto, aveva ai piedi scarpe da ginnastica imitazione Fila, misura da ragazzino, e vestiva in modo anonimo con una predilezione per i giubbotti di jeans, dentro cui teneva d’abitudine una Smith & Wesson Special a canna corta. Dove gli altri tenevano le Marlboro. Ma Totuccio non fumava, quindi lo spazio per la 38 c’era. Portava sempre con sé un santino di Padre Pio, vicino ai proiettili di scorta.
La mano miracolosa, per chi fa il killer, è come l’Iva per gli artigiani: devi sempre poterla aggiungere se il cliente lo richiede.
Stabilito che la piazza era vuota, si accucciò vicino a una 127 bianca che, sotto le luci gialle e povere di piazza Scaffa, sembrava color ittero. Dovevano vedersi alle tre. Per parlare. O per morire.
Marinello arrivò con Rosalba poco dopo; avevano preso la Fiesta carta da zucchero dei genitori di lei. Parcheggiarono lungo corso dei Mille, a cento metri da piazza Scaffa. Il muso in fuori, pronti a partire.
«Tu resta qui, amore mio» disse lui poggiandole una mano sulla coscia.
Lei ubbidì, spostandosi al volante: aveva appena preso il foglio rosa, non era esperta, ma ingranare la prima e scappare, questo sì, l’aveva imparato subito. Avrebbe dovuto evitare quella fila disordinata di cassonetti, una barricata postmoderna da cui emanava un fetore orribile, omaggio involontario e sacrilego alla Battaglia di Ponte dell’Ammiraglio dipinta da Guttuso. Lo slancio delle camicie rosse, le sciabole brandite, i picciotti che morivano per un’Italia mai così lontana per la popolazione di Palermo, che era stata schiacciata durante i moti del 1820 e non si era mai più risollevata. Eppure le camicie rosse avevano combattuto, e avevano vinto.
Marinello non sapeva niente di tutto questo quando si avvicinò ai cassonetti pensando che Rosalba avrebbe dovuto essere brava a evitarli, in slalom, se le cose si fossero messe male. Se lui fosse stato ucciso.
Controllò la cintura di cuoio che teneva sui jeans. All’altezza della fibbia aveva infilato la Beretta M9 Parabellum, da film americano. Dietro, con il calcio che toccava la schiena, la 7,65, più maneggevole. Si guardò le scarpe: Adidas rosse scamosciate, le tre strisce bianche sporche di terra e polvere. E decise di andare incontro alla propria famiglia che lo attendeva da qualche parte, magari in agguato dietro a una di quelle automobili in sosta.
Totuccio lo vide avanzare. Si rialzò: quella era questione da uomini in piedi.
«Cugino, devi essere uomo. O vieni con noi subito, lasci quella buttana, fai quello che la famiglia ti dice, oppure…» scandì.
«Oppure cosa, pezzo di merda?» quasi urlò Marinello.
Si trovavano a quindici metri uno dall’altro, di fronte. Erano cresciuti insieme: stesse feste, stessi battesimi, diversi destini.
Marinello voleva la sua libertà e per questo era pronto a uccidere.
«Oppure cosa?» ripeté abbassando la voce.
«Oppure ti sparo qui. Sei sangue del mio sangue, e non ti scannerò a tradimento. Ti do la possibilità di difenderti, come si fa tra uomini. Facciamo a chi spara prima, però sei libero di scegliere: torna con noi e ce ne andiamo a casa.»
Nessuno dei due aveva ancora armi in mano. La luce giallognola dei lampioni illuminava i cassonetti, due carcasse bruciate di automobili, le cassette per la frutta accatastate all’angolo tra via Brancaccio e corso dei Mille, dove nasceva piazza Scaffa.
Dalla sua Fiesta, Rosalba poteva distinguere in lontananza le due sagome. La più vicina era Marinello, più in là l’uomo che avrebbe deciso della loro vita.
Vide un primo lampo. Poi un secondo. Nel giro di pochi istanti i lampi divennero quattro, cinque. Le due figure si spostavano poco, come se non volessero schivare i colpi. Marinello cadde in ginocchio, e il cuore di lei si fermò. Non sentiva più nulla, funzionavano solo gli occhi, fissi sull’altro uomo che si avvicinava, trascinando una gamba e cercando qualcosa dietro alla schiena: la seconda pistola. Tutto si rimise in moto, a velocità doppia.
Sta per sparargli in testa, sta per sparargli in testa.
Il movimento di Rosalba fu rapido: mettere in moto la Fiesta, evitare la barricata di cassonetti, sgommare verso l’uomo che si avvicinava a Marinello, costringendolo a buttarsi a terra per non essere travolto dall’auto, frenare, raccogliere il suo uomo e scappare via. Verso un luogo dove ancora capivano il siciliano.
(Riproduzione riservata)
© HarperCollins Italia – Giuseppe Di Piazza
* * *
La scheda del libro
 Due innamorati divisi, come Romeo e Giulietta. Una ragazza belga, stupenda e malinconica, che nasconde un terribile segreto. Un medico per bene con simpatie fasciste. Un malacarne buono a nulla che rapisce i suoi tre figli. Un “ladro onesto”, fratello di un mercante di uova di tonno alla Vuccirìa. Queste le persone che popolano le giornate di Leo Salinas, detto “occhi di sonno”, un giovane cronista di nera che ogni sera torna a casa con le scarpe sporche di sangue umano. E tanta voglia di vita e bellezza. Perché è Palermo, sono gli anni Ottanta, la giovinezza in una città sconvolta dalle guerre di mafia. Ma anche un luogo unico, di profumi, di chiese, cibo e mare. E donne bellissime, che come sirene promettono meraviglia e possono portare salvezza o perdizione. “I quattro canti” è il nome con cui gli abitanti della città chiamano la piazza che nasce dall’incrocio delle due strade principali, perché ogni suo angolo apre su uno dei quattro quartieri storici. Qui, riproponendo una versione riveduta, ampliata e corretta del suo libro di esordio, Giuseppe Di Piazza compone un quinto canto, inaspettato e fondamentale, “un canto impercettibile alla vista, il più visibile per chi è andato via da Palermo: il canto dell’assenza”. E così facendo regala al lettore un libro eccezionale, una “commedia umana” siciliana e noir che è tante cose insieme: cinque storie diverse che però sono una storia sola, il racconto della passione e del delitto, della speranza e della disperazione, una denuncia durissima contro la mafia da parte di un autore che, come il protagonista, ha vissuto quegli anni terribili e sanguinosi in prima persona. E, ovviamente, un infinito atto di amore nei confronti di una città.
Due innamorati divisi, come Romeo e Giulietta. Una ragazza belga, stupenda e malinconica, che nasconde un terribile segreto. Un medico per bene con simpatie fasciste. Un malacarne buono a nulla che rapisce i suoi tre figli. Un “ladro onesto”, fratello di un mercante di uova di tonno alla Vuccirìa. Queste le persone che popolano le giornate di Leo Salinas, detto “occhi di sonno”, un giovane cronista di nera che ogni sera torna a casa con le scarpe sporche di sangue umano. E tanta voglia di vita e bellezza. Perché è Palermo, sono gli anni Ottanta, la giovinezza in una città sconvolta dalle guerre di mafia. Ma anche un luogo unico, di profumi, di chiese, cibo e mare. E donne bellissime, che come sirene promettono meraviglia e possono portare salvezza o perdizione. “I quattro canti” è il nome con cui gli abitanti della città chiamano la piazza che nasce dall’incrocio delle due strade principali, perché ogni suo angolo apre su uno dei quattro quartieri storici. Qui, riproponendo una versione riveduta, ampliata e corretta del suo libro di esordio, Giuseppe Di Piazza compone un quinto canto, inaspettato e fondamentale, “un canto impercettibile alla vista, il più visibile per chi è andato via da Palermo: il canto dell’assenza”. E così facendo regala al lettore un libro eccezionale, una “commedia umana” siciliana e noir che è tante cose insieme: cinque storie diverse che però sono una storia sola, il racconto della passione e del delitto, della speranza e della disperazione, una denuncia durissima contro la mafia da parte di un autore che, come il protagonista, ha vissuto quegli anni terribili e sanguinosi in prima persona. E, ovviamente, un infinito atto di amore nei confronti di una città.
* * *
© Letteratitudine – www.letteratitudine.it
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo
Seguici su Facebook e su Twitter
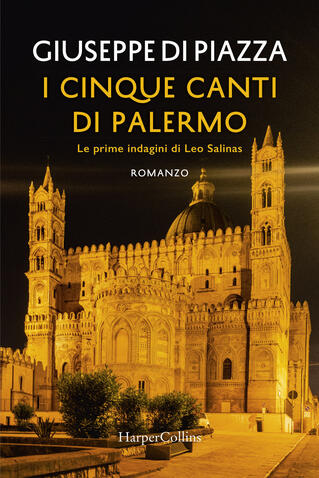 “I cinque canti di Palermo. Le prime indagini di Leo Salinas” di Giuseppe Di Piazza (HarperCollins Italia): incontro con l’autore e un brano del libro
“I cinque canti di Palermo. Le prime indagini di Leo Salinas” di Giuseppe Di Piazza (HarperCollins Italia): incontro con l’autore e un brano del libro Noi raccontavamo il mattatoio di Palermo, lo sterminio da parte di Totò Riina e dei corleonesi di ogni loro avversario, antica mafia palermitana o poliziotti e giudici che fossero.
Noi raccontavamo il mattatoio di Palermo, lo sterminio da parte di Totò Riina e dei corleonesi di ogni loro avversario, antica mafia palermitana o poliziotti e giudici che fossero.
 Due innamorati divisi, come Romeo e Giulietta. Una ragazza belga, stupenda e malinconica, che nasconde un terribile segreto. Un medico per bene con simpatie fasciste. Un malacarne buono a nulla che rapisce i suoi tre figli. Un “ladro onesto”, fratello di un mercante di uova di tonno alla Vuccirìa. Queste le persone che popolano le giornate di Leo Salinas, detto “occhi di sonno”, un giovane cronista di nera che ogni sera torna a casa con le scarpe sporche di sangue umano. E tanta voglia di vita e bellezza. Perché è Palermo, sono gli anni Ottanta, la giovinezza in una città sconvolta dalle guerre di mafia. Ma anche un luogo unico, di profumi, di chiese, cibo e mare. E donne bellissime, che come sirene promettono meraviglia e possono portare salvezza o perdizione. “I quattro canti” è il nome con cui gli abitanti della città chiamano la piazza che nasce dall’incrocio delle due strade principali, perché ogni suo angolo apre su uno dei quattro quartieri storici. Qui, riproponendo una versione riveduta, ampliata e corretta del suo libro di esordio, Giuseppe Di Piazza compone un quinto canto, inaspettato e fondamentale, “un canto impercettibile alla vista, il più visibile per chi è andato via da Palermo: il canto dell’assenza”. E così facendo regala al lettore un libro eccezionale, una “commedia umana” siciliana e noir che è tante cose insieme: cinque storie diverse che però sono una storia sola, il racconto della passione e del delitto, della speranza e della disperazione, una denuncia durissima contro la mafia da parte di un autore che, come il protagonista, ha vissuto quegli anni terribili e sanguinosi in prima persona. E, ovviamente, un infinito atto di amore nei confronti di una città.
Due innamorati divisi, come Romeo e Giulietta. Una ragazza belga, stupenda e malinconica, che nasconde un terribile segreto. Un medico per bene con simpatie fasciste. Un malacarne buono a nulla che rapisce i suoi tre figli. Un “ladro onesto”, fratello di un mercante di uova di tonno alla Vuccirìa. Queste le persone che popolano le giornate di Leo Salinas, detto “occhi di sonno”, un giovane cronista di nera che ogni sera torna a casa con le scarpe sporche di sangue umano. E tanta voglia di vita e bellezza. Perché è Palermo, sono gli anni Ottanta, la giovinezza in una città sconvolta dalle guerre di mafia. Ma anche un luogo unico, di profumi, di chiese, cibo e mare. E donne bellissime, che come sirene promettono meraviglia e possono portare salvezza o perdizione. “I quattro canti” è il nome con cui gli abitanti della città chiamano la piazza che nasce dall’incrocio delle due strade principali, perché ogni suo angolo apre su uno dei quattro quartieri storici. Qui, riproponendo una versione riveduta, ampliata e corretta del suo libro di esordio, Giuseppe Di Piazza compone un quinto canto, inaspettato e fondamentale, “un canto impercettibile alla vista, il più visibile per chi è andato via da Palermo: il canto dell’assenza”. E così facendo regala al lettore un libro eccezionale, una “commedia umana” siciliana e noir che è tante cose insieme: cinque storie diverse che però sono una storia sola, il racconto della passione e del delitto, della speranza e della disperazione, una denuncia durissima contro la mafia da parte di un autore che, come il protagonista, ha vissuto quegli anni terribili e sanguinosi in prima persona. E, ovviamente, un infinito atto di amore nei confronti di una città.






