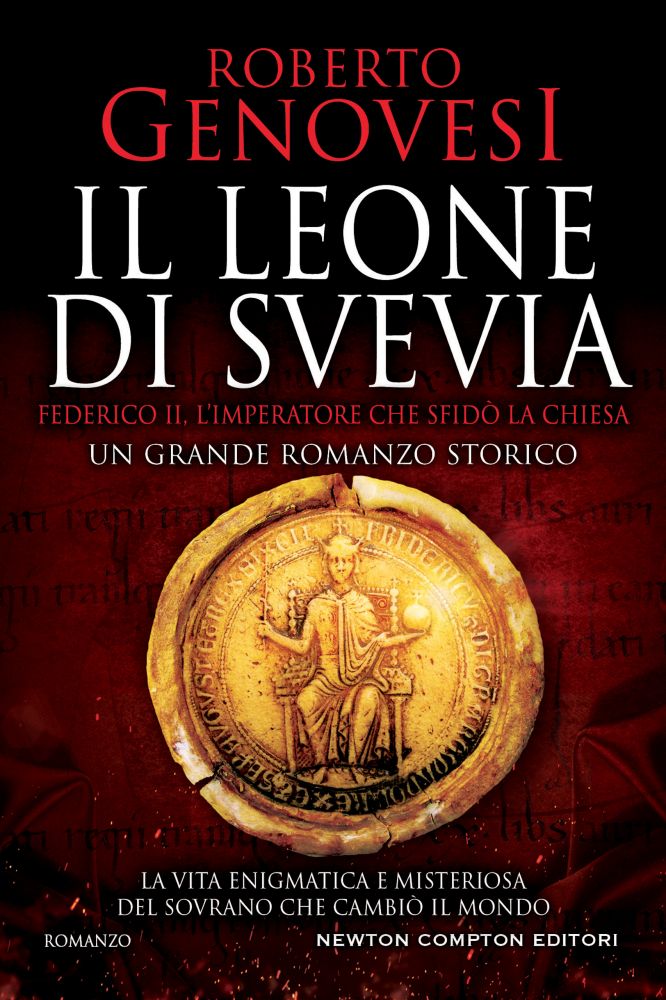 “Il leone di Svevia”di Roberto Genovesi (Newton Compton): incontro con l’autore e un brano estratto dal libro
“Il leone di Svevia”di Roberto Genovesi (Newton Compton): incontro con l’autore e un brano estratto dal libro
* * *
Roberto Genovesi è giornalista, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo. Dirigente RAI, è Direttore Artistico di Cartoons on the Bay, il festival internazionale delle arti visive crossmediali e Responsabile dei Progetti Speciali di Rai Com. Ha collaborato con i più importanti periodici e quotidiani italiani tra cui «L’Espresso», «Panorama», «TV Sorrisi e Canzoni», «la Repubblica». Insegna Teoria e Tecnica dei linguaggi interattivi e crossmediali in diverse università. Con la Newton Compton, oltre ai primi cinque volumi della saga della Legione occulta (La legione occulta dell’impero romano; Il comandante della Legione occulta; Il ritorno della Legione occulta. Il re dei Giudei, I due imperatori e I guardiani di Roma), ha pubblicato La mano sinistra di Satana; Il Templare nero, Il leone di Svevia e la trilogia La legione maledetta (Il generale dei dannati, La fortezza dei dannati e L’invasione dei dannati). I suoi romanzi sono pubblicati anche in Spagna, Portogallo e Inghilterra. Il suo sito è: www.robertogenovesi.com
Il nuovo romanzo di Roberto Genovesi è il già citato Il leone di Svevia (Newton Compton).
Abbiamo chiesto all’autore di parlarcene…
* * *
«Ci sono personaggi che ti entrano in testa e non ne escono più», ha detto Roberto Genovesi a Letteratitudine. «Sarà per affinità elettive, per comuni radici culturali o geografiche o più semplicemente per simpatia epidermica. Per me, con Federico di Svevia sono successe tutte queste cose. Le mie radici sono pugliesi (parte della mia famiglia viene dal Gargano), amo le persone curiose che non si fermano mai davanti agli ostacoli, sono un pacifista convinto, come cristiano non sopporto la secolarità della Chiesa e trovo affascinante la possibilità che le grandi religioni monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) possano dialogare grazie alle radici comuni. Alla luce di queste premesse, Federico II non poteva che essere il mio uomo, che ho letto, studiato, analizzato per anni e trasformato in una graphic novel già una decina di anni fa, con i disegni di quel grande maestro che fu Sergio Toppi per i tipi dei Periodici San Paolo.
 Ed è stato proprio da lì che ho cominciato, per scrivere Il leone di Svevia. Anzi, dal suo principale coprotagonista, che ho mutuato pari pari dal fumetto: Ahmed Addid, comandante della guardia saracena di Federico e suo grande amico fin dall’infanzia. Un personaggio fittizio, che ho rafforzato e migliorato nel romanzo partendo dal profilo accennato nelle tavole disegnate. E che mi è servito proprio per raccontare il Federico diverso dal solito che avevo in mente.
Ed è stato proprio da lì che ho cominciato, per scrivere Il leone di Svevia. Anzi, dal suo principale coprotagonista, che ho mutuato pari pari dal fumetto: Ahmed Addid, comandante della guardia saracena di Federico e suo grande amico fin dall’infanzia. Un personaggio fittizio, che ho rafforzato e migliorato nel romanzo partendo dal profilo accennato nelle tavole disegnate. E che mi è servito proprio per raccontare il Federico diverso dal solito che avevo in mente.
Scrivere l’ennesima biografia romanzata del falco di Svevia sarebbe stato inutile (ce ne sono tante ed esaustive) e pretenzioso (perché firmate da nomi ben più autorevoli del mio). Sul figlio di Apulia è stato scritto proprio tutto e anche il contrario di tutto. Vicende limpide ma anche fatti controversi. Episodi chiari ma anche storie dai retroscena oscuri. Una cosa è certa e riconosciuta da tutti: Federico Costantino fu un sovrano diverso da quelli del suo tempo (e non solo per la portata geografica del suo potere), e anche da quelli che vennero dopo. Troppo avanti nel pensiero, troppo illuminato, troppo attento ad ascoltare e a dialogare più che a offendere, almeno fino a quando i suoi detrattori glielo hanno permesso. Osannato, invidiato, adorato, temuto.
Lo ammetto, nello scrivere Il leone di Svevia non sono stato imparziale, o quantomeno non ho voluto guardare Federico con distacco. Ho cercato invece di entrare nella testa dell’uomo: del bambino abbandonato nelle strade di Palermo, una vicenda che, vista estrapolata dal contesto, potrebbe sembrare un gesto di crudeltà, ma che alla luce dei fatti si rivelò la sua fortuna, perché lo mise in condizione di incontrare altre culture e altre religioni nella fase della vita in cui a guidare è l’istinto, e non le sovrastrutture che la società impostata degli adulti costruisce; del re adolescente, affiancato da una consorte più grande di lui che alla fine si rivelò la consigliera matura che gli serviva in periodo di immaturità; e infine dell’imperatore adulto, che seppe fronteggiare con piglio e personalità prima i papi e poi i sovrani nemici. Ho accennato le vicende storiche e mi sono soffermato sulle reazioni emotive dell’essere umano di fronte alla politica, alla guerra, all’amore. Ho raccontato i dubbi, le pressioni, i sentimenti: uno, indelebile, è quello dell’amicizia, l’altro, devastante, è la passione amorosa per una ragazzina come Bianca Lancia, e saranno gli unici punti di riferimento indiscutibili della sua vita, insieme alla fiducia paterna per il prediletto Manfredi.
Ho raccontato un Federico che ride, piange, si spaventa, esulta, ruggisce. Un leone per un mondo che non lo meritava ancora e che forse non lo meriterà mai. Un sovrano capace di sparigliare le carte, di dettare nuove regole laddove poteva sembrare impossibile, di portare un cristiano e un musulmano dentro una tenda per parlare di astri e non di guerra, di formule matematiche e non di conquiste. Di questi tempi, con i venti di guerra che aleggiano nel mondo, avremmo tutti bisogno di un Federico di Svevia. Sono convinto che sarebbe ancora in grado di stupire il mondo».
* * *
Un brano estratto da “Il leone di Svevia”di Roberto Genovesi (Newton Compton)
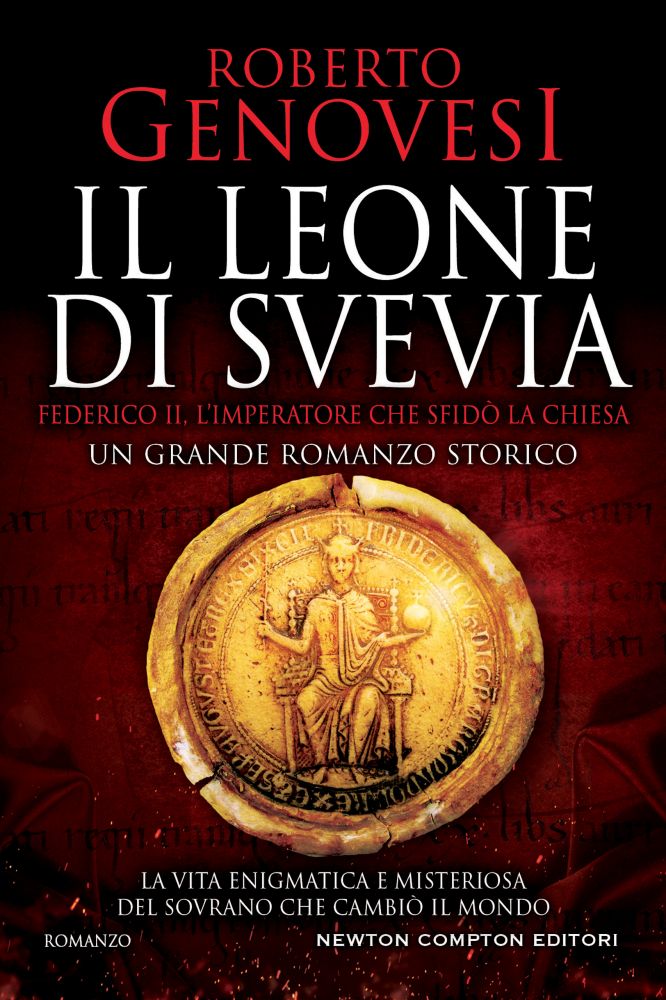
Palermo, Regno di Sicilia, novembre 1198 d.C.
Il Cassaro era una cittadella fortezza, divisa dagli altri quartieri
di Palermo da alte mura e due fiumi che parevano stringerla in
un gigantesco abbraccio. Il palazzo reale sembrava un gioiello
incastonato in quel grande anello quadrangolare, isolato dal
resto della città da un ponte levatoio di modeste proporzioni
ma immerso nei suoi odori, nelle sue multiformi voci dialettali e
raggiunto da tutte le sue strade, su cui transitavano ogni giorno
senza soluzione di continuità i carri diretti al mercato di porta
Patitelli.
Il bambino che abitava in quel castello amava trascorrere molto
tempo a guardare quel traffico di animali, barche, colori e umori.
Ruote cigolanti, bestie nervose, remi affaticati. Il suo mondo, che
andava ben oltre i confini di quella piccola stanza appollaiata sulla
torre occidentale, lontana dai movimenti di palazzo ma dall’alto
della quale le mura che difendevano la dimora dei normanni di
Sicilia non avevano più segreti. Avvisato ogni mattina dall’afrore
delle bestie portato dal vento, si precipitava ad affacciarsi in punta
di piedi dalla bifora che correva sul balconcino rivolto al mare, sicuro
che di lì a poco avrebbe scorto in lontananza la lenta colonna
degli armenti e i carri piegati dal peso degli enormi barili di spezie
e del ferro degli armaioli, seguiti da una lunga coda multicolore
di stoffe dai pigmenti pregiati, che da lontano facevano sembrare
quell’insieme di uomini, bestie e merci un gigantesco pappagallo
assonnato. Palermo apriva i cancelli ogni mattina a quel mondo,
e diventava per buona parte della giornata il cuore pulsante del
commercio siciliano. Ma c’erano dei giorni speciali, quelli in cui i
precettori non assillavano il bambino con il disegno o l’abecedario.
In quelle rare occasioni il piccolo, con la complicità di grate
troppo strette per un soldato e cunicoli troppo angusti per un
servo, sfuggiva al controllo delle guardie e delle dame di corte e
si gettava nella mischia. Diventava così uno dei tanti orfani vestiti
di stracci di cui brulicavano le strade della città. Incurante dei
pericoli, armato solo della buona sorte che sovente accompagna
i cuccioli e della spavalderia di chi ancora non conosce davvero
il mondo, il bambino aveva imparato a memoria la strada per
uscire dal palazzo reale. Ma anche quella per arrivare nel più
breve tempo possibile alla sua destinazione preferita: la Kalsa, il
malfamato e decaduto quartiere musulmano dove lo aspettavano
ogni volta gli altri piccoli cavalieri dell’indigenza.
Quel giorno, la pioggia fina ma incessante non aveva dissuaso
la processione di mercanti dall’adempiere al loro rito
quotidiano, e anzi aveva potenziato gli odori che si portavano
dietro, eccitando ancor di più l’immaginazione del bambino
che, pur di uscire presto, aveva deciso di sfidare i tempi delle
ronde. Tuttavia, non trovò gli ostacoli che si sarebbe aspettato
a quell’ora. Tutte le dame di corte e gran parte della popolazione
del castello si alternavano ormai da giorni al capezzale di
sua madre. Costanza stava male e non accennava a migliorare.
Nessun medico, per quanti ne fossero stati cercati e convocati,
era riuscito a venirne a capo. E in quel periodo di confusione
nessuno aveva più badato al bambino che, indisturbato, continuava
a rispettare il suo rito quotidiano.
Così, Federico uscì ancora una volta dalla fortezza senza che
nessuno glielo impedisse. Ma non prima di aver ficcato in un
sacco il suo nuovo copricapo. Il capo di una banda deve portare
un segno di riconoscimento, e quale miglior oggetto poteva fare
al caso suo se non la corona di re di Sicilia che gli avevano messo
in testa solo una settimana prima?
Florentium, Capitanata, Apulia Normanna, dicembre 1250 d.C.
«Aprite! Presto!», urlò l’uomo a cavallo minacciando i battenti
serrati del fortilizio. Nonostante la distanza segnata dal fossato
che circondava la cittadella, la sua voce giunse forte e chiara ai
soldati che sostavano sulla torre di guardia.
«Chi sei? Cosa ti porta fin qui al calar del sole? Non è orario da
gentiluomini, questo!», osò rispondere uno di essi, sporgendosi
dal parapetto per guardare meglio.
Uno scapaccione che quasi gli fece volar via dalla testa l’elmo
lo raggiunse ancor prima che il lontano cavaliere gli vomitasse
addosso tutti gli improperi possibili.
«Stupido!», disse la voce del capo delle guardie. «Non vedi che
è Ahmed Addid!». Poi si piegò in avanti e urlò verso il basso.
«Abbassate il ponte! Immediatamente!».
Con un sonoro cigolio di catene, il ponte levatoio cominciò
a calare. Quando toccò terra con un tonfo, il cavallo nero si
impennò per scaricare tutta la sua impazienza e poi si tuffò al
galoppo nella fortezza, lasciandosi alle spalle l’ennesima sferzata
gelida. Quando ebbe superato le mura perimetrali piantò gli
zoccoli anteriori a terra sollevando una nuvola di neve. L’uomo
in sella non ebbe nemmeno il tempo di apprezzare l’immediato
aumento della temperatura prodotto dai numerosi fuochi che i
soldati avevano acceso lungo i camminamenti. Si guardò intorno
più volte, e finalmente vide sopraggiungere trafelato il capo delle
guardie che lo aveva fatto entrare.
«Dove si trova l’imperatore?», chiese cercando lontano nella
semioscurità.
Il capo delle guardie indicò una sagoma lontana che si stagliava
come una picca spuntata su un orizzonte violaceo.
«Come sta?», chiese tirando le redini del destriero impaziente.
La risposta che lesse nello sguardo del soldato lo spinse a
conficcare i talloni nei fianchi dell’animale fino a farlo nitrire
di dolore.
Ahmed Addid attraversò la cittadella a testa bassa. Una lunga via
longitudinale portava direttamente dall’accesso meridionale alla
domus solaciorum che Federico si era fatto costruire sulle rovine
di un precedente castello. Ma per arrivarci, bisognava attraversare
tutto il sobborgo tempestato di viuzze perpendicolari che
di giorno ospitavano il viavai di commercianti, artigiani e clienti
di giudici e notai. Florentium era una cittadella laboriosa ma
isolata nel contesto della Capitanata che perfino la Chiesa aveva
scelto come buon ritiro, edificando al suo interno una cattedrale
e almeno altre sei chiese, gestite da pochi canonici.
A quell’ora, quando anche il sole aveva deciso di trovare requie,
quelle stradine erano deserte e silenziose, e il rumore forsennato
degli zoccoli del cavallo nero che le attraversava di gran carriera
somigliava al monologo di un tamburo da battaglia.
Quando anche l’ultimo degli edifici gli sfilò accanto, Addid
vide la sagoma del castello normanno fare capolino oltre l’inclinarsi
della via. Trattenne il suo cavallo appena in tempo per non
travolgere una processione di frati che stava uscendo dall’edificio
principale, guidata dalla luce di alcune candele. Il consueto
viatico dei moribondi.
Addid saltò giù dal cavallo e lanciò solo uno sguardo a uno
stalliere che gli stava venendo incontro. Afferrò per il cappuccio
il primo dei frati che gli capitò a tiro.
«Ditemi che è ancora vivo».
Il frate lo guardò per un attimo senza interrompere subito la
litania che stava recitando. Poi socchiuse le palpebre. «Non lo
sarà ancora per molto, ma… sì, egli vive ancora».
Addid sollevò lo sguardo al cielo. Una fioca luce arancione si
intravedeva tra le grate dell’ultimo piano in cima alla torre più
alta. «Allah sia ringraziato», sussurrò prima di precipitarsi dentro.
I suoi stivali appesantiti dalla neve lasciarono enormi chiazze di
ghiaccio sulle mattonelle disposte in opus spicatus che portavano
alla scala a chiocciola che saliva ai piani superiori. Tutti coloro
che si trovavano all’interno della domus si fecero silenziosamente
da parte per lasciarlo passare. Guardie impettite, signorotti locali
ancora disposti all’ossequio, nobiluomini di corte pronti a farsi
riconoscere. A nessuno di loro Addid regalò uno sguardo o un
cenno. Affrontò i gradini di pietra, e contandoli uno a uno arrivò
in cima in un tempo che gli parve infinito.
All’ultimo piano lo accolsero tre porte identiche e chiuse.
L’uomo esitò, ma alla fine una di esse si aprì per lasciare uscire
un’ancella, che portava tra le braccia una pila di panni che trasudavano
ancora calore. Alle sue spalle, nello spazio tra la porta
e lo stipite, quella stessa luce arancione che aveva visto dal basso
lo spinse a entrare.
Ad accoglierlo fu un intenso tanfo di feci, con un fastidioso
retrogusto di incenso. Addid tossì rumorosamente per nascondere
il conato di vomito che gli stava salendo in gola. Chinò il
capo per portarsi una mano davanti alla bocca. Quando riuscì
a risollevare gli occhi, si ritrovò a guardare un uomo, seduto su
un trono di legno vicino a un materasso di lana di pecora, che un
baldacchino spartano sollevava di mezza spada dal pavimento di
marmo rosa. Intorno al letto, alcune giovani monache stavano
recitando il rosario a bassa voce. Le loro ombre distorte venivano
gettate sulle pareti dalla luce arsa dei bracieri. L’uomo sul trono
aveva gli occhi chiusi, unico dettaglio riconoscibile su un volto
nascosto da una folta chioma riccioluta, che un tempo era stata
rossa come il rame ma che adesso annaspava nel colore di un’alba
asfittica. Un servo aveva appena finito di tagliargli la barba
e ora se ne stava in un angolo a fissare il vuoto, con in grembo
un piatto d’argento pieno di peli. La foresta arrugginita che gli
aveva lasciato in faccia declinava sulle guance, senza riuscire a
nascondere il dimagrimento incipiente a cui la malattia aveva
sottoposto l’uomo assopito.
Addid si avvicinò lentamente alla poltrona di legno, maledicendo
lo scricchiolio dei suoi stivali di cuoio provati dal freddo. Un
lenzuolo di lino candido appena cambiato era adagiato sul corpo
di Federico e ne disegnava con maniacale precisione le forme
ossute. I vestiti dell’imperatore giacevano invece su una panca nei
pressi della finestra che si affacciava sui giardini della tenuta. Una
lunga veste di broccato blu e un giustacuore di cuoio martellato
rinforzato da fibule d’argento. Addid provò una stretta al cuore.
Ma a provocarla non fu la vista di quell’uomo magro e indifeso.
Non fu la vista di occhi infossati nelle orbite o il movimento
appena accennato del torace. Non fu l’espressione di generale
rassegnazione che poteva leggere sui volti di tutti coloro che si
trovavano nella camera da letto dell’imperatore. A trafiggergli il
petto come uno stilo ardente fu vedere che la servitù aveva già
preparato gli abiti migliori dell’imperatore. Quelli necessari per
presentarsi al cospetto di Dio.
(Riproduzione riservata)
© Newton Compton
* * *
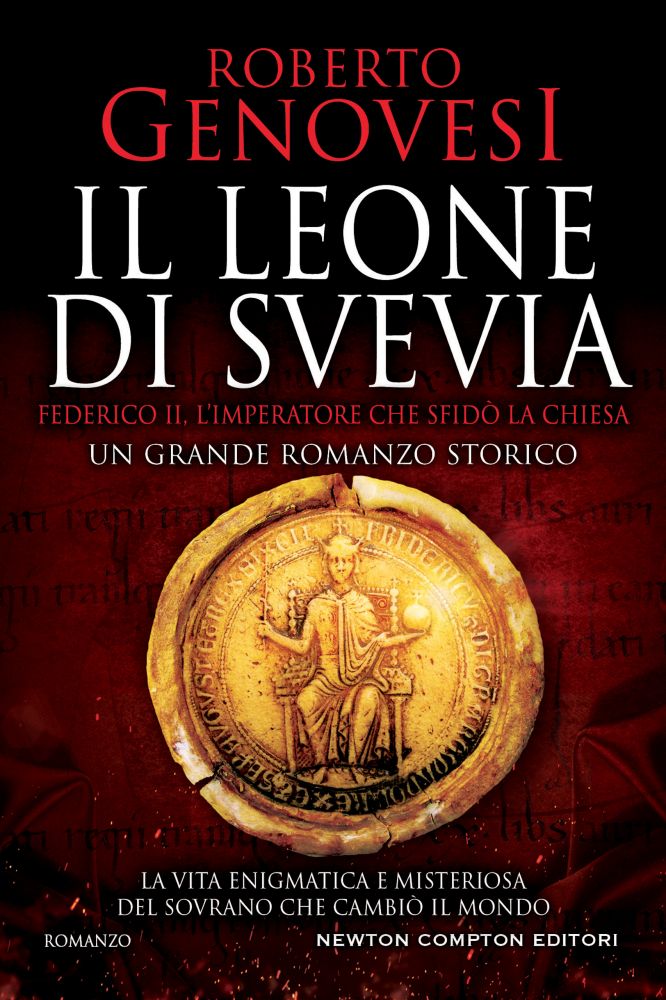 La scheda del libro: “Il leone di Svevia”di Roberto Genovesi (Newton Compton)
La scheda del libro: “Il leone di Svevia”di Roberto Genovesi (Newton Compton)
Federico II, l’imperatore che sfidò la Chiesa. Un grande romanzo storico. La vita enigmatica e misteriosa del sovrano che cambiò il mondo
Dicembre 1250. Durante una battuta di caccia, Federico di Svevia viene colto da un forte malore e portato nella residenza di Castel Fiorentino. A tutti diviene presto chiaro che le condizioni dell’imperatore non sono destinate a migliorare e che il suo tempo su questa terra sta arrivando al termine. Federico convoca quindi al proprio capezzale il fidato Ahmed Addid, capo della guardia saracena e amico d’infanzia per impartirgli un ultimo ordine: vuole ascoltare il racconto della propria vita e comprendere come il mondo lo ricorderà attraverso l’unica voce che non gli mentirebbe mai. Ahmed ricostruisce così un sincero ritratto del suo signore, lontano dall’immagine che ne hanno i suoi sudditi: la storia di un bambino che cresce tra paure e dubbi, menzogne e rifiuti, fino a diventare prima re e poi imperatore. Una vita all’insegna della forza d’animo e dell’ambizione, tanto grandi da mettere in ginocchio anche la più grande potenza dell’occidente: la Chiesa.
* * *
© Letteratitudine – www.letteratitudine.it
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo
Seguici su Facebook – Twitter – Instagram
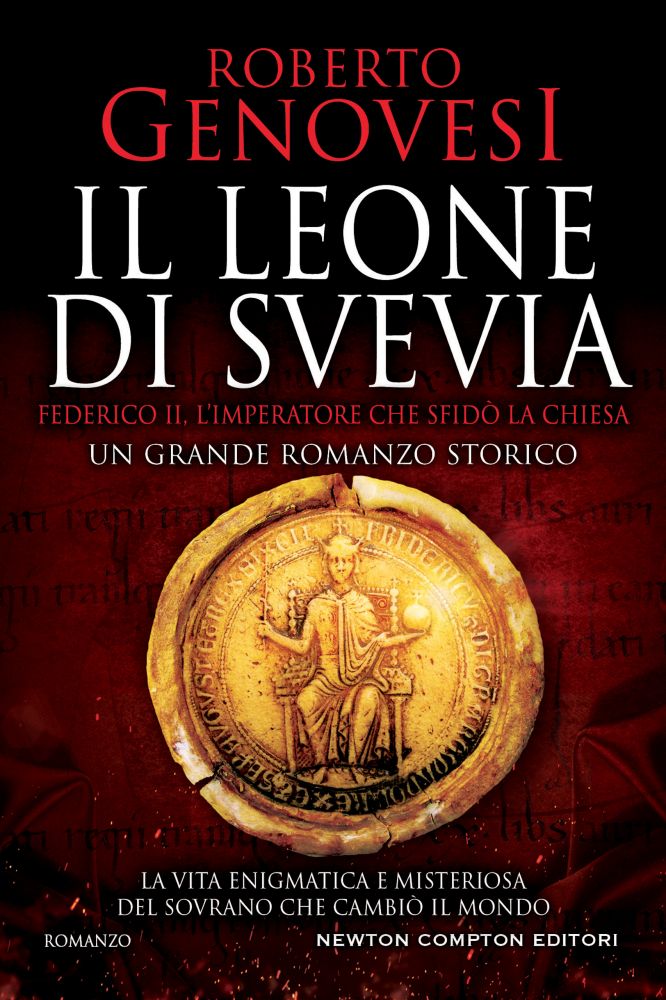 “Il leone di Svevia”di Roberto Genovesi (Newton Compton): incontro con l’autore e un brano estratto dal libro
“Il leone di Svevia”di Roberto Genovesi (Newton Compton): incontro con l’autore e un brano estratto dal libro Ed è stato proprio da lì che ho cominciato, per scrivere Il leone di Svevia. Anzi, dal suo principale coprotagonista, che ho mutuato pari pari dal fumetto: Ahmed Addid, comandante della guardia saracena di Federico e suo grande amico fin dall’infanzia. Un personaggio fittizio, che ho rafforzato e migliorato nel romanzo partendo dal profilo accennato nelle tavole disegnate. E che mi è servito proprio per raccontare il Federico diverso dal solito che avevo in mente.
Ed è stato proprio da lì che ho cominciato, per scrivere Il leone di Svevia. Anzi, dal suo principale coprotagonista, che ho mutuato pari pari dal fumetto: Ahmed Addid, comandante della guardia saracena di Federico e suo grande amico fin dall’infanzia. Un personaggio fittizio, che ho rafforzato e migliorato nel romanzo partendo dal profilo accennato nelle tavole disegnate. E che mi è servito proprio per raccontare il Federico diverso dal solito che avevo in mente.






